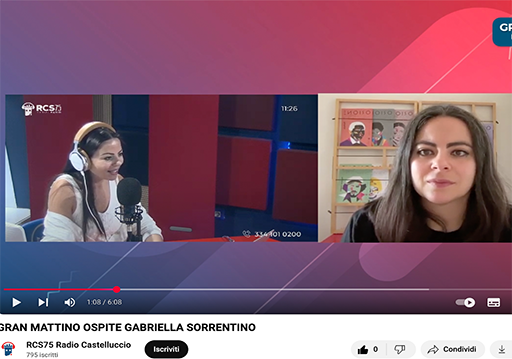Man mano che sono andata avanti nella lettura dei pezzi però, mi sono resa conto che è successo un fatto molto interessante: nonostante l’aforisma si proponeva più e più volte, il discorso che ne scaturiva era sempre diverso, eppure sempre molto valido. E così ho ripensato a Steven Pinker, che ne L’istinto del linguaggio sosteneva, già nel 1997, l’immensa vastità del linguaggio, dove secondo un calcolo breve ma che non riporterò in questa sede, «ognuno di noi è capace di pronunciare un infinito numero di enunciati». Che in poche parole, mi sembra significhi — in senso lato — che ognuno di noi può dire quello che vuole, ammesso che abbia conoscenza di un ampio numero di parole. Ecco, io ora vorrei porre l’accento su quella che è una splendida facoltà che si differenzia molto dalla possibilità: non sempre è auspicabile infatti dover dire. L’avvento dei social ci fa utilizzare il linguaggio (verbale, video, dei meme e qualsiasi altro tipo di linguaggio) in maniera molto — troppo — leggera, di quella leggerezza che non tiene conto delle possibili conseguenze. Penso, per esempio, a quella plètora di influencer che dallo scranno della tastiera si ergono a giudici e moralisti — e a quei tantissimi follower che, privi di riferimenti educativi di valore, assumono per oro colato tutte queste parole che a volte si rivelano anche deleterie. Si ha l’illusione di una democrazia allargata, dove finalmente si può comunicare al mondo la propria opinione. Questo però succede in un contesto virtuale, dove i nostri discorsi servono ai motori di ricerca per capire come segmentare il mercato e cosa, come e quando vendere i loro prodotti (credevate davvero che Facebook fosse un modo per farvi divertire?) per massimizzare i profitti. Nessuno, se non le grandi multinazionali che acquistano i dati, è realmente interessato a quello che dite sui social. All’altro estremo invece, la bolla degli articoli scientifici,1 dove spesso gli autori sono talmente tanti che il contributo di ciascuno è quasi nullo, si verifica che alla fine il numero di questi supera il numero dei lettori, considerando anche il fatto che i contenuti sono divulgati attraverso canali talmente specialistici che non riescono a raggiungere neanche il pubblico cui sono destinati. Ecco dunque che la facilità con cui si può prendere la parola produce una libertà illusoria, ma al contempo queste parole dette sono piume e macigni. Sempre Pinker: «Quando riversiamo parole nelle orecchie di un interlocutore, agiamo su di lui e riveliamo le nostre intenzioni, onorevoli o no, con la stessa sicurezza come se lo stessimo toccando». Violazioni intenzionali delle norme non dette della conversazione a parte (come ad esempio l’ironia, il sarcasmo, la metafora, la retorica e altre figure retoriche o espedienti linguistici), ancora una volta sostengo fermamente che le parole possono produrre cambiamenti — ed è proprio per questo che sono importanti. E, a pensarci bene, una parola, se pronunciata, fisicamente, non è altro che aria insufflata. Cosa c’è di più leggero dell’aria? Pensate però a quanto l’aria può essere devastante se vi si agisce una forza: bufere, uragani e tempeste non sono altro che aria. E ancora, le parole potrebbero essere anche inchiostro o byte, e anche qui ritrovo la leggerezza; l’unica cosa che potrebbe aumentare il loro peso specifico resta il significato — e l’intenzione del parlante. L’invito dunque è quello di sempre: sceglietele con cura, le parole.
NOTE
1 Le migliori università d’Europa: solo 4 italiane fra le prime cento e nemmeno una nella top ten — La Repubblica — 10 luglio 2024
BIBLIOGRAFIA
Steven Pinker: L’istinto del linguaggio — Oscar Saggi Mondadori — 1997
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU ORIONE N. 32, “LEGGEREZZA”, NELLA SEZIONE EDITORIALE — SETTEMBRE-AGOSTO 2024
Per leggere il numero 32 di Orione, Leggerezza, clicca qui.

Per leggere tutti i numeri di Orione, clicca qui.
L’articolo è disponibile anche qui.