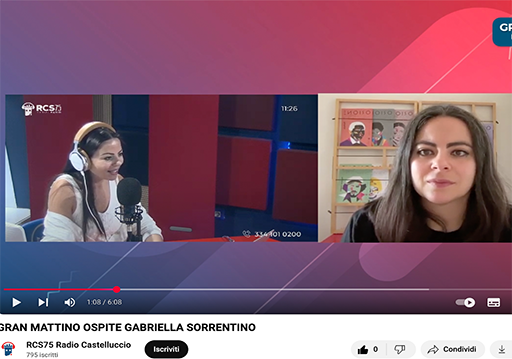Lui non se ne è mai accorto — o non lo ha mai fatto vedere — che puntualmente in classe mancava circa un quarto dei presenti durante le sue ore di presunto “italiano”. Prendeva in giro i più deboli, quelli che combattevano battaglie private per via di non essere abbastanza alti, magri, ricchi o belli, in un’età in cui l’accettazione sociale e il desiderio di appartenenza a un gruppo sembrano essere la preoccupazione principale. Si addormentava coi piedi incrociati sulla cattedra, la faccia nascosta dal quotidiano, nelle quattro ore del tema in classe — ore in cui, spauriti come non mai, raggranellavamo parole, significati e sensi pur di produrre qualcosa — qualsiasi cosa — e riempire quei fogli bianchi, visto che lui — lo scopriremo solo a due trimestri dall’esame di stato — non ci aveva dato neanche i rudimenti delle forme testuali che avremmo incontrato di lì a breve per la prova scritta. Saggio breve, articolo di giornale, analisi testuale erano forme di espressione pressoché sconosciute; in compenso non ci risparmiava epiteti razzisti, richiami sessisti, offese gratuite e toni grevi. La frustrazione che provavo durante quelle ore era terribile. Nonostante questo ero affascinata dal mondo delle parole. Mi piacevano i libri — col tempo ho imparato ad apprezzarne anche altre qualità, come l’odore, la forma, la copertina, ho iniziato a vedere il libro come prodotto e dunque come progetto, facendone poi una professione — mi piaceva il modo in cui un parlante può utilizzare — scegliere — le parole e creare così disposizioni e relazioni; evocare immaginari, fantasie, costruire mondi altri. Era il superpotere del dare la forma al pensiero. E me lo ha insegnato uno dei miei primi supereroi: la superprof di inglese. Mi dava parole di un’altra lingua, avevo un vocabolario intero da imparare. Dovevo chiedere «Ciao, come ti chiami? Da dove vieni?» con una grammatica che non mi apparteneva, e soprattutto, iniziavo a fare quello che avevo fatto coi libri italiani: leggere. Così teacher mi presentò libri su libri, uno su tutti a me particolarmente caro: Wuthering Heights. In quel libro c’era tutto: l’odore della carta logora (lo avevo recuperato in un mercatino delle pulci), nuove parole da imparare, frasi con un potere fortissimo; e c’era anche l’eroe negativo di cui poi mi sarei innamorata e da cui non sarei mai guarita. Heathcliff è pallido, malaticcio, esile, biondino e fragile (non proprio il mio tipo); non ha un carattere forte e deciso, non è simpatico. Eppure, tutta la storia è incentrata sulla forte passione tra lui e Cathy, anche se non sarà una storia rose e fiori. Così, uno dopo l’altro, i miei eroi erano dentro i libri: fuori dalla società e dalle convenzioni. Quelli che mi piacevano sentivano intensamente le passioni, avevano un vivissimo senso dell’avventura, appagando così il bisogno di libertà e il senso di individualismo che li descriveva; anime in pena, vaganti per territori inesplorati, e spiriti selvaggi che preferivano andare pur di non sottostare ai rigidi schemi dell’autorità e delle sovrastrutture culturali. Coltivavano l’immaginazione: punto cruciale del processo creativo, alimentata dalle forze della natura. Terra, vento, acqua e fuoco, gli elementi che aiutavano a definire il soprannaturale e il magico. Visioni, sogni, incubi, fantasmi erano le finestre attraverso le quali accedere al mondo dell’introspezione: la ricerca dell’infinito, superare il limite per il semplice gusto dell’oltre. Cioè, tipo una persona a cavallo lanciata a galoppo coi capelli sciolti, al vento. Quello che mi chiedo è dove siano finiti tutti questi modelli, e perché, ogni volta che mi fermo a riflettere sul concetto di (super)eroe che, in teoria, dovrebbe salvarmi dal lupo cattivo, mi viene in mente una figura femminile. In fondo, non basterebbe che questo. Passione, e amore.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU ORIONE N.16, “I SUPEREROI”, NELLA SEZIONE EDITORIALE — APRILE 2019
Per leggere il numero 16 di Orione, I supereroi, clicca qui.

Per leggere tutti i numeri di Orione, clicca qui.
L’articolo è disponibile anche qui.