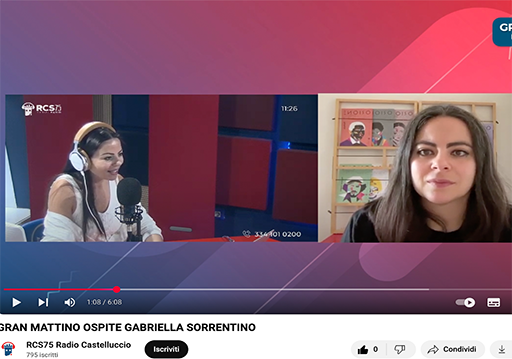Un po’ come quando, per allenare la meditazione e la concentrazione, ti chiedono di non pensare all’elefante bianco. Qual è la prima cosa a cui pensate? È che, quando hai di fronte la faccia dell’attore che per due stagioni interpreta il più cattivo dei cattivi, non puoi fare a meno di guardarlo con un po’ di paura, eccitazione e inconfessabile ammirazione. Lo incontro così, in questo stato di timore, a Palazzo Merulana a Roma, dove prendiamo un caffè e dove, solo dopo un’ora, mi confessa «ho accettato quest’intervista perché ho visto la bontà e la qualità di Orione e ci tenevo a dare il mio contributo».
Noi abbiamo pensato a te perché ogni volta che riflettiamo su un tema per Orione, cerchiamo di definirlo e di tracciarne limiti e confini. Spesso per definire qualcosa abbiamo bisogno anche del suo opposto. E tu vieni al grande pubblico per l’interpretazione dell’antieroe per eccellenza, Don Pietro Savastano, boss del clan camorrista.
L’antieroe per definizione deve rimanere tale. C’è tutta una drammaturgia, una letteratura sull’antieroe che è molto affascinante. Sono figure che spuntano sempre in periodi di grandissimi cambiamenti epocali. Quando i riferimenti sociali cominciano a vacillare, quando le figure su cui si proiettano una serie di cose cominciano a vacillare. Sta cambiando un’epoca, cambia il mondo e le proiezioni. In questi momenti storici di fratture nascono gli antieroi, è sempre interessante seguirne le tracce perché spesso sono portatori di visioni. Anticipano quello che accadrà. Penso ad esempio a Čhecov, Dostoevskij, al cinema americano indipendente. Hanno raccontato gli antieroi, che sono le figure che portano su di sé le malattie di un’epoca. Se pensi a Un giorno di ordinaria follia — meraviglioso. L’antieroe si prende la responsabilità di portare la malattia del sociale e la esterna in maniera anche confusa. Gli antieroi che amo di più sono quelli che non sono consapevoli del loro portato poetico, altrimenti non sarebbero antieroi. Non sanno cosa stanno inseguendo, cosa stanno sviluppando, però sentono dentro un disagio relativo alla loro epoca, ai modi di vivere, ai valori e se ce la fanno urlano questo disagio.
Perché non ti piace essere riconosciuto come Don Pietro Savastano?
Mica non mi piace. Io sono orgoglioso di aver interpretato quel ruolo. Il punto è che cerco sempre di tradire chi c’è dall’altra parte, perché non sempre incontro persone che hanno la capacità di discernere. Se ho di fronte ragazzi molto giovani, rispetto a quello che hanno visto sullo schermo, è bene tradirli: facendogli sentire come parlo — non ho la voce di Savastano —, facendogli capire che il mio dialetto ha fatto dei percorsi diversi e che quando voglio lo uso, quando non mi serve non lo uso; mi piace tradire quegli aspetti in modo che sia subito chiaro e lampante che Savastano è una maschera e che dietro c’è un essere umano. Se proprio qualcuno deve emulare qualcosa, se ci sono dei contenuti che ritiene interessanti, meglio che emuli la persona e non il personaggio in sé.
Perché gli antieroi fanno presa?
Fanno presa perché dicono quello che gli altri non dicono. Spesso parlano di fragilità. Se leggi Čhecov, il suo Ivanov dice a un certo punto, nell’imbarazzo generale degli altri, quello che passa a tutti per l’anima ma che coprono con meccanismi eroici che in realtà cominciano a cedere, e attecchiscono perché sono sinceri, perché non cercano di imporre o proporre strutture, menzogne; ma, a costo anche del loro equilibrio personale, denunciano il malessere che si portano dentro, se ne fanno portatori. Chi non riesce a capire il suo portato, a volte in contrasto con quello che c’è all’esterno, scivola ahimè su un piano di malattia mentale, di disagio, di abbandono da parte degli altri.
Fortunato nel tuo libro Se vuoi vivere felice edito da Einaudi, diventa antieroe quando inizia a diventare vittima del gioco, in contemporanea però è il momento in cui lui si sente più gagliardo.
In quel caso Fortunato è portatore di un disagio familiare. Una volta ho letto da qualche parte una cosa che mi è molto piaciuta, che dice che, in generale, chi si ammala in un nucleo sociale — la famiglia, in questo caso — non è mai il più debole ma è il più forte: è quello che denuncia agli altri, con il proprio vissuto, quello che non va. Fortunato con quel gesto — questo è venuto fuori grazie a quello che nel tempo gli analisti che ho incontrato mi hanno restituito — dissonante, forte, è lì per urlare agli altri che c’è qualcosa che non va. Penso che dietro molti disagi, come ad esempio la droga, esistono urla di disperazione non ascoltate. Qualche volta riuscire a intercettare il contenuto di queste urla, significa aiutare gli altri. Io credo che gli antieroi, se ascoltati in questo senso, potrebbero essere un valore aggiunto alla riflessione sul sociale.
Chi ha la responsabilità sociale della deriva in comportamenti antieroici? La famiglia, il contesto, la scuola… lo Stato?
Vedi, noi possiamo stare qui a parlare di scuola per anni; possiamo parlare del valore dello Stato, del valore di inserire nei tessuti sociali delle palestre, delle biblioteche — e a volte si fa pure, però se non si ha la consapevolezza del perché, è un po’ inutile. Molto spesso questi luoghi diventano cattedrali nel deserto, luoghi vuoti, non abitati; a volte finanziamenti vengono buttati al vento così, perché queste cose poi non vengono curate, perché di base manca la consapevolezza. Io credo che finché non si avrà la consapevolezza che la società in cui viviamo non è a misura di bambino, non a misura di donna, non a misura di anziano, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa, perché si è rotto un circolo. Se non si capisce il valore della narrazione, della memoria, della saggezza — ma, soprattutto, trasmissione del sapere di una società, vuol dire che c’è qualcosa che si sbaglia, perché poi i ragazzi crescono nel nulla, senza radici, senza un passato.
Il titolo del romanzo è Se vuoi vivere felice. Qual è il motivo per cui si diventa felici?
Io ho una bambina di 18 mesi — che si chiama Delfina [ndr] — e non so se questo è il motivo per cui si diventa felici. Il romanzo non è una ricetta di felicità e non vuole esserlo e anche l’idea di felicità che propongo non è una cosa standard. Noi siamo nell’immantinenza, sempre. Tutto è soggetto alle leggi del cambiamento, della trasformazione. Quindi, se qualcuno insegue una felicità stabile nel tempo, probabilmente fallirà nella sua ricerca perché è come la natura: oggi c’è il sole, poi pioverà… bisogna essere disponibili e aperti ai cambiamenti e alle trasformazioni. La felicità è riuscire a trovare il senso, probabilmente, di questi cambiamenti e di questa continua instabilità. La felicità è fatta di momenti, di istanti — istanti di consapevolezza — per poi andare nel casino, nella confusione, in tutto quello che la vita ordinaria ci propone. Riuscire a mantenere attimi di presenza, anche di fronte alla confusione, forse questa è la cosa che assomiglia di più all’idea di felicità che mi sono fatto.
Qual è il rapporto tra analisi, di cui dici avere grande esperienza, e scrittura curativa?
Sono due cose molto diverse che non bisogna confondere. Spesso un buon libro, una buona lettura, ma anche buona musica, Mozart, Beethoven, sono sempre curativi, perché ti aiutano a fare sintesi, a prendere la goccia che poi diventerà arcobaleno. Ma l’analisi è una cosa seria che va fatta con professionisti e non bisogna illudersi di avere gli strumenti per poterla fare da soli. Ci si può aiutare molto e si può aiutare il lavoro dell’analista, ci sono degli esperimenti di autoterapia che funzionano, però il confronto con un altro essere umano che sta lì e ti dice delle cose — basate sulla conoscenza e sul loro know-how specifico — ha sicuramente un valore aggiunto. Così è per la scrittura: posso avere un istinto per la scrittura, un talento, però poi le tecniche bisogna impararle, altrimenti si rischia di chiudersi in un riflesso di se stessi.
Nel libro c’è Nicolino, un bambino «un pò strano». L’hai incontrato veramente? Come ti relazioni a lui o al suo personaggio?
Tutti i personaggi del libro sono reali, anche se poi vi è intorno una costruzione narrativa, il tentativo di costruire un’architettura della storia. Tutto quello che ho raccontato è vero. Io sono molto legato a Nicolino, anche se oggi non so dove sia. Quando lo vedevo giocare, era “il diverso”: quello di cui si ha paura, che ti fa scattare i sensi di colpa, che ti costringe alla riflessione. Il diverso-da-evitare. A me i diversi piacciono sempre.
Noi lavoriamo con i contrasti: proviamo a rompere gli schemi delle narrazioni precostituite e a portare avanti una cultura delle diversità, per andare oltre.
Sicuramente queste condizioni portano un carico di sofferenza enorme. Non voglio esaltare quest’aspetto, perché poi chi è dentro queste cose magari potrebbe fraintendere le mie parole; però quando si è dentro, riuscire a capire qual è la propria qualità, nonostante il disagio derivante dalla diversità, è molto importante. Poi il diverso è sempre un rivoluzionario.
Qual è la rivoluzione da mettere quotidianamente in atto?
L’attenzione per il prossimo. Dare fiducia alle persone, avere fede.
Qual è il tuo rapporto con la fede?
Io seguo l’insegnamento del buddismo tibetano, a volte parlo di Cristo in maniera un po’ più libera perché non appartengo alla cristianità. Ho scoperto Cristo attraverso il buddismo, attraverso la cultura orientale e finalmente mi sono liberato, ero imbrigliato in una serie di sovrastrutture che non mi facevano vedere le cose come realmente sono. Ad esempio, “loro” ti fanno concentrare molto sul senso di colpa, sul concetto di sofferenza. Non si concentrano sulla vita come dono, sulla vita come meraviglia costante — sulla vita come costante possibilità. Sei sempre sul non essere degno. Per citare le parole del Nazareno, «Siamo tutti fratelli», «Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te», credo che questi siano insegnamenti fondamentali. A volte ci illudiamo di essere tante individualità — e di fatto lo siamo — ma io credo che lo scherzo di un unico ipotetico Dio sia proprio in quello che dicono i Grandi Maestri: siamo una sola cosa.
Chi era il tuo supereroe da bambino?
Ne ho avuti tanti. Ancora oggi guardo le serie televisive con grande passione (infatti mia moglie mi prende in giro). Ricordo con molto amore e anche delicatezza Superman. Mi piaceva l’idea non tanto che avesse i superpoteri, ma il fatto che fosse un diverso. Ricordo le immagini di questo bambino che sente di essere portatore di questa diversità. Lui viveva in questa capanna, con i genitori — ma non era figlio loro… Questo sentirsi costantemente non in linea con il mondo che lo circondava è una cosa che mi ha sempre molto commosso. Io davo quasi un valore tragico a Superman, nel senso bello del termine. La tragedia è l’altra faccia della commedia. Guardavo questo bambino che era portatore di una eccezionalità che era l’altra faccia della diversità.
Se oggi potessi avere dei superpoteri, quali sceglieresti?
Ce li abbiamo già i superpoteri — ma non li usiamo: siamo esseri umani. Essere umano è un’opportunità gigantesca. Io e te abbiamo gli stessi, identici superpoteri. Potenziare i superpoteri che ci sono stati dati significherebbe tanto. Usare quello che abbiamo, usarlo per davvero… Saremmo già uomini straordinari. Siamo tutti supereroi ma viviamo come persone ordinarie.
In Se vuoi vivere felice descrivi molte emozioni. Qual è l’emozione più grande che colleghi a questo lavoro?
Il rilassamento. Per Fortunato adulto, incontrare la sua storia, incontrare il bambino, è stato come un abbandono, nato da una tensione. Quando ho ripreso i quaderni che erano stati i miei diari, molte cose non volevo ricordarle. Il confronto è stato molto teso, sul filo della lama. Qualche taglietto me lo sono fatto, perché durante il lavoro sono emerse molte cose del passato, però poi, dopo questo processo, guardo il bambino, me stesso, con più gratitudine. Poi, la libertà. Liberazione dal passato… perché i bambini, soprattutto quando vivono situazioni di violenza, non sono capaci di capire cosa sta succedendo, quindi hanno sempre bisogno di un adulto che li aiuti a venire fuori. E la cosa paradossale è che mentre l’adulto aiuta il bambino, a sua volta è aiutato dal bambino.
A questo punto, commossa, gli confesso una delle mie fragilità — che non confesserò anche a voi.
Guarda, tutto questo si basa su un equivoco: l’equivoco della normalità. Magari dico una cosa che è già stata detta — ma forse non abbastanza. Che cos’è la normalità? È una serie di convenzioni alle quali noi aderiamo per essere accettati dagli altri. Spesso dietro il concetto di normalità c’è la paura, la paura di essere rifiutati. E questo crea più disastri della diversità. I fenomeni del bullismo, del rifiuto sociale, della violenza, spesso sono figli dell’idea di aderire a una normalità che poi cambia in base al territorio, quindi già di per sé non può essere universale perché è soggetta alle circostanze. Quindi essere normali non è altro che una recita per non rimanere soli. Ci si accorda su alcune cose, ma c’è un selvaggio dentro di noi che ci dà altre possibilità. Ecco che per me il concetto di normalità è un concetto abbastanza equivoco. Detto questo, è necessario avere delle convenzioni alle quali aderire, perché altrimenti saremmo nel far west, ognuno farebbe come gli pare; ma bisogna essere consapevoli che si tratta di convenzioni, non di certezze.
Gli chiedo se c’è qualcosa tra le cose dette che non vuole che scriva. Mi risponde, con la più grande serietà che finora ho visto sul suo volto: «Questo puoi saperlo solo tu». Così, dimentico di ringraziarlo per il caffè, ma non smetto di sorridere per il fatto che, incontrando Fortunato, ho finalmente sconfitto Don Pietro Savastano. Sono anche io un Supereroe, no?
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU ORIONE N.16, “I SUPEREROI”, NELLA SEZIONE INTERVISTA — APRILE 2019
Per leggere il numero 16 di Orione, I supereroi, clicca qui.

Per leggere tutti i numeri di Orione, clicca qui.
L’articolo è disponibile anche qui.